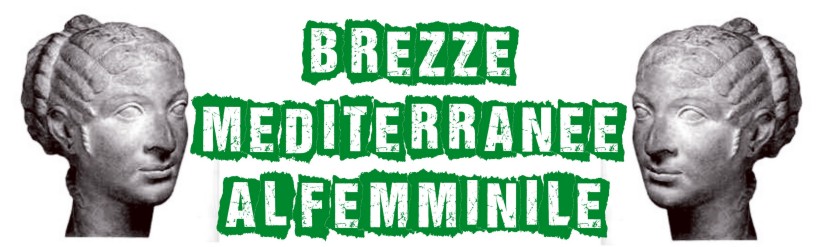L’incipit è tipico di un romanzo giallo. Muore la signora Ivette Ferrioli, per un malore improvviso. Il maresciallo che fa il sopraluogo trova in un pacchetto alcune buste consumate dal tempo contenenti lettere. Le consegna alla dirigente della Sezione Omicidi, Olga. La dirigente, incuriosita, inizia a leggere queste lettere. Si tratta di una corrispondenza tra due giovani che inizia nel 1939. Poi Stefano Chiusi parte per la guerra. La stessa dirigente si lascia coinvolgere sempre di più dalle vicende contenute nella corrispondenza che ci fa rivivere il dramma della guerra, la “tragica avventura” e il “mondo mostruoso che supera ogni immaginazione”. Stefano viene fatto prigioniero e così alcune lettere hanno come oggetto la sua vita trascorsa “ in un luogo chiuso da staccionate di filo spinato, quasi gabbie, ai limiti del deserto”. La corrispondenza si interrompe senza chiarire la sorte di Stefano e sarà la dirigente della Omicidi, spulciando tra altre carte, a convincersi della morte di Stefano. L’interesse di questa corrispondenza sta nel farci conoscere non solo la vita privata di una coppia dell’epoca con un bambino che non conoscerà mai il padre, ma anche ci permette di concepire lo stato d’animo di una nazione attraverso la testimonianza di un soldato della seconda guerra mondiale.
Brezze di mare è una raccolta di dieci racconti. Da “Giovanna la Pescatrice”, dal sapore fiabesco e fantastico a “Il Paese del mio Sud” dove una telefonata della figlia che è prossima a partorire fa rivivere antichi ricordi sulla vita nelle campagne e su antiche ricette di cucina. Da “Donna Letizia” dove viene sfiorato il problema della ragazze madri a “La Casetta dalle Tegole Rosse” con le figure di nonna Filomena e nonno Rocco. Da “Giardino Lido di un Tempo” dove facciamo la conoscenza del barone Giampieri, che sa camminare con i tempi, al contrario della moglie donna Valeria che rimane legata al suo passato.
Da “Una visita eccellente”, dove una visita all’amico Nicola in una villa al mare che si conclude con l’uccisione di un ospite atteso , Beniamino Petra a “La Partenza di zia Isabella per l’America” con considerazioni che possono interessare gli emigranti di ogni tempo.
E poi “Il Caffè al bar” con una perfetta descrizione degli anni cinquanta e uno spaccato sui rapporti fra l’alta borghesia e i commercianti di mercerie;
“L’Abito Bianco”, una tipica storia di rancori covati fra parenti ed infine “Il Passerotto alla Fonte”, storia di un amore sbocciato tra due giovani.
Qualche considerazione sulla prosa della De Angelis è senza dubbio nitida, precisa, chiara,efficace, talvolta mordace. Il tema dei ricordi riaffiora prepotentemente nei suoi racconti. E con essi un pizzico di malinconia e di rimpianto. Ma l’autrice non appartiene- si badi bene- alla schiera dei laudatores temporis acti né rimpiange le buone cose di pessimo gusto di gozzaniana memoria. Anzi, qua e là, la descrizione degli avvenimenti passati è vista con sottile umorismo. Il tempo in cui siamo vissuti- sembra dire la De Angelis-era quello. Del resto è lo stesso Ecclesiaste che ammonisce :”Non dire mai: perché i tempi antichi erano più felici dei presenti? Non è una domanda intelligente. “Dai racconti risaltano i temi cari alla nostra autrice: riferimenti autobiografici; ricordi dell’infanzia; forti legami con la famiglia; l’attaccamento alla Calabria e a Reggio in particolare e infine l’amore. Tutti questi temi, insieme alla varietà dei sentimenti che vanno dalla nostalgia alla speranza, dal dolore alla gioia, tornano nei versi di “Gemme, fiori e foglie”.
Ma la poesia della De Angelis – conclude Nino Megali - non esprime solo sentimenti, ma può descrivere anche un animale, un paesaggio, un luogo. Il verso è limato, scorrevole e terso. Attraverso queste rime la poetessa riesce a comunicare con noi raccontandoci non solo una serie di fatti, ma trasmettendoci emozioni, sensazioni e sentimenti. La parola è passata alla poetessa Antonietta De Angelis Del Medico che ha esordito affermando “Scrivere per me è stato un momento di grazia, oserei dire un momento di intensa illuminazione che mi ha spinto a ricordare i racconti interiori, le identità di alcune figure di donne. Una misteriosa illuminazione che mi ha spinto a parlare di donne che nella più onesta semplicità hanno rappresentato e rappresentano ancor oggi la parte migliore, la punta di diamante di questa nostra Calabria”.
Si tratta quindi di donne non famose (quali quelle che la letteratura per lo più ci tramanda), ma che certamente dotate di un forte potere interiore hanno saputo portare fuori la luce delle pluralità delle anime del nostro Sud. Esse sono madri, spose, amiche tutte governate dall'amore verso i figli, la famiglia, gli amici, i parenti o da questo volto dell'amore stesso (dall'uomo verso la donna e viceversa) ancor oggi misterioso e incomprensibile come ne la bella favola di Psiche.
Vero è che la posizione della donna, fin dalle origini della storia dell'umanità appare e nel campo sociale e nell'impressione della propria personalità e in quello politico e giuridico sempre in subordinata a quella dell'uomo.
Già il codice di Hannurabi del 1752 a.C. riconosceva all'uomo il controllo sulla prole e sulla sessualità femminile ed ancora dagli Assiri nel 1200 a.C. il corpo della donna era considerato di assoluta proprietà maschile o del padre o del fratello o del marito fino a giungere in Oriente alle Tragiche separazioni dell'Harem. In questo luogo i sovrani avevano la possibilità di mantenere tutte le concubine che volessero in quanto sinonimo di potenza e grandiosità.
Si legge che Dario ne ospitasse 365 e che un re sassanide del 531 d.C. ne ospitasse dodici mila.
Che se da una parte la parola Harem può evocare un mondo fantastico, fatto di trasgressione e profumi mai sentiti, dall'altra non può che suggerirci che un'umana pietà verso tutte quelle donne che, rinchiuse e velate, sono state obbligate a condividere lo stesso uomo su comando.
Anche nella società greca precristiana, vigeva un'accentuata disparità tra i sessi. Le donne, specialmente quelle appartenenti alle classi privilegiate, sottoposte e soggette alla tutela del marito o del fratello, potevano lasciare l'abitazione solo per particolari circostanze … (le famose visite di lutto!)
La civiltà romana, pur legata a queste consuetudini affiderà tuttavia alle donne il compito morale di madre ed educatrice dei figli e vale a questo punto ricordare la figura di Cornelia, madre dei Gracchi nobili tribuni della plebe del 130 a.C. E dunque si narra che Cornelia, rimasta vedova in giovane età, avesse rifiutato di sposare il re di Egitto del tempo per consacrarsi tutta all'educazione dei figli. Ed ancora si dice che ad una matrona romana, che le ostentava i suoi monili, mostrasse i suoi figli dicendo: “Ecco i miei gioielli”. Non a caso a lei più tardi sarà eretta nel Foro romani una statua con questa semplice scritta: “A Cornelia madre dei Gracchi”.
E certamente da questo tempo in poi il grande flusso della storia delle donne romane emergerà per più vicende.
Tuttavia le consuetudini relative alla discriminazione delle donne diedero vita, a seconda delle aree geografiche, a differenti culture e comportamenti fin nelle società più complesse e sviluppate dei secoli successivi.
La rivendicazione della sua uguaglianza giuridica e politica con l'uomo ha inizio solo nell'età moderna e nei paesi occidentali. I primi fermenti si hanno nel Settecento ma il vero e proprio affermarsi si ha durante la Rivoluzione del 1789 in Francia passando poi per la Germania, l'Inghilterra e l'America.
Ma solamente dopo un iter faticoso e complesso di più di due secoli questo cammino raggiungerà la sicura va al godimento di tutti i diritti civili (diritto di voto, eleggibilità alle cariche amministrative, politiche).
Ed oggi certamente con i mutamenti socio/economici e tecnologici si vanno affermando nuovi valori e nuove idee che assai spesso sembrano contrastanti con quelle del passato legate soprattutto alla saggezza dei comportamenti.
Leggiamo ne “Le conversazioni di Venerdì” di Achille Walter Cannizzaro: “Anche le donne come l'eroe Ulisse oggi vogliono scoprire ciò che ancora non si conosce e spesso si dimenticano di seguire la via della prudenza e quindi della saggezza”.
Ma a questo mondo della saggezza e governato dall'occhio dell'amore non ancora sopraffatto dai mutamenti, quando la vita si manteneva uniforme secondo i modelli della tradizione e tuttavia con spinte nuove appartengono queste mie protagoniste del primo e del secondo novecento. Questo secolo breve appena alle nostre spalle.
È dunque per estensione potremmo dire – continua la professoressa Antonietta De Angelis Del Medico, che queste donne non ancora pienamente acculturate, ma dall'animo forte quasi virile tratte dalla vita provinciale, vivendo concretamente ed ubbidendo alla morale comune, libere nella giusta via cogliendo il senso vero dell'umanità ci aiutano a risolvere il dramma fondamentale dell'oggi incapace di stabilire una legge assolutamente morale, cioè vera sia sul piano affettivo e individuale sia su quello intellettuale e sociale.
Tutto questo rappresentano le mie donne da “Il caso della signora Ivette” a “Brezza di mare”.
Donne capaci d'amore che ci consentono di giungere quasi alla radice della vita umana.
Ma c'è di più – prosegue la professoressa Antonietta De Angelis Del Medico – queste mie opere sarebbero potute rimanere confuse se la mia esperienza ed i miei studi non mi avessero guidato verso una ricerca che, volta a creare intorno un'architettura di bellezza, mi ha permesso di aggiungere alla penetrazione del senso umano ed alle atmosfere dei tempi pennellati di colore estremamente veri e partecipi e la memoria dei luoghi sostenuti da un forte sentimento religioso così che – in una lettura che si fa seguire senza fatica anche gli elementi della natura (dal mare ai fiori, dalle piante al volto morbido delle nostre colline, ai profumi) sono entrati a farne parte viva e portante, umilmente cercando di raggiungere quel vertice artistico che dire all'Alighieri nel suo canto XI dell'Inferno al verso 105 “che l'arte a Dio quasi è nipote”.
Ed infine -conclude la poetessa Antonietta De Angelis Del Medico - data la serata, in omaggio alla nostra città ed alla nostra giovinezza “Lido Comunale” un racconto con presenze femminili variegate e vivaci e dove la vicenda socio politica pur di notevole spessore (viviamo il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica del 1947) è presentata in chiave garbatamente umoristica, quasi dilettantistica